Disobbedisco
- Redazione

- 30 mar 2025
- Tempo di lettura: 4 min
Di Alessio Moroni
Sono trascorsi più di cento anni dall’impresa di Fiume guidata da Gabriele D’Annunzio. Eppure, il suo
lascito, per quanto lontano nel tempo, è attualissimo.
L’Italia si trovava in una situazione drammatica, erede di una guerra che aveva fatto disperdere
l’ottimismo dei primi anni del ventesimo secolo, insieme alle vite di molti cittadini italiani, scomparsi
per difendere il vessillo tricolore dall’attacco delle potenze nemiche. Per i sopravvissuti alla Grande
Guerra, il ritorno nelle proprie case fu traumatico. Si doveva ritornare alla routine quotidiana dopo
aver trascorso giorni, settimane e anni interminabili nelle trincee, nella speranza che il nemico
facesse un passo falso e si rendesse attaccabile. Giovani che avevano vissuto Caporetto, il momento
da cui la nostra storia cambiò per sempre e ci diede la fama di guerrieri mai domi, sul punto di
soccombere nonostante la disfatta ormai certa. Merito del generale Armando Diaz, che guidò milioni
di italiani alla rivalsa, e di quelle stesse persone che continuarono a non far entrare lo straniero.
Furono questi ragazzi, di differente matrice politica (fra i legionari di Fiume c’erano nazionalisti,
socialisti, anarchici), a voler seguire il famoso poeta pescarese nella conquista della sopracitata città
portuale. Non volevano tornare alla solita vita quotidiana, ma erano intenzionati a essere pervasi
nuovamente dalla dose di adrenalina che un conflitto e un’impresa del genere potevano garantire.
L’eterogeneità della conquista e dell’intera epopea fiumana ci consente di vedere un nesso fra tal
movimento e le contestazioni del ’68: entrambe, fomentate dalle giovani generazioni, volevano
vedersi riconoscere numerosi diritti civili e sociali, ma la differenza fra le due – e che fu punto di forza
della prima – è stata la capacità di porre all’apice delle proprie istanze la questione nazionale. Si
doveva combattere prima di tutto per l’Italia, per renderla uno Stato in cui tutti avessero avuto gli
stessi diritti, le stesse libertà e le stesse possibilità di raggiungere un compiacimento personale.
La Carta del Carnaro, stilata nel 1920 dal sindacalista socialista Alceste De Ambris, ci presenta una
Costituzione moderna in cui i perni erano l’uguaglianza e la sovranità popolare, senza distinzione di
sesso, religione, lingua, razza e classe, e il diritto ad avere un’istruzione garantita, un salario minimo,
la pensione e qualsiasi altro tipo di rivendicazione sociale.
La Reggenza del Carnaro si presentò come un esperimento avanti coi tempi. Fondamentale (e non
avrebbe potuto essere altrimenti con la presenza di intellettuali come D’Annunzio e Marinetti) fu il
ruolo dell’arte e della musica all’interno dei propri confini: strumenti per elevare il popolo e per
ostentare il proprio ruolo di città all’avanguardia nell’Europa del tempo.
Vennero rimossi anche tutti i moralismi borghesi: Fiume era una città libertaria e libertina, dove
venivano concesse le libertà di orientamento sessuale e dove non erano posti freni ai propri istinti
inibitori.
Tutto ciò non poteva andar giù alla classe politica del tempo, guidata da Francesco Saverio Nitti: non
si poteva restare impassibili nell’osservare comportamenti che andavano a inficiare la decenza
pubblica e, soprattutto, nel clima del primo dopoguerra, non si tolleravano azioni che potevano
andare a destabilizzare i già precari equilibri creati nel vecchio continente dopo il Trattato di
Versailles.
Si preferiva la conservazione dello status quo piuttosto che la rivendicazione di quei territori prima
promessi e poi non concessi.Anche i Fasci italiani di combattimento, guidati da Benito Mussolini (seppure non avesse la carica di
segretario ma solamente di membro del comitato centrale), si dimostrarono restii a ostentare la
propria ammirazione per ciò che stava accadendo nell’attuale Paese croato. Il futuro Duce riteneva
che bisognasse focalizzarsi sulla rivoluzione sociale all’interno dei confini italiani e non intraprendere
campagne militari per acquisire nuove terre, tanto che D’Annunzio gli rinfacciò lo scarso impegno
economico per aiutarlo nell’impresa.
È importante ricordare come non tutti seguirono questa linea di pensiero e, anzi, nel 1921, a seguito
del Patto di pacificazione fra fascisti e socialisti, Italo Balbo e Grandi si recarono dallo scrittore e
drammaturgo abruzzese per chiedere di divenire la nuova guida del movimento fascista, senza però
ricevere una risposta affermativa. D’Annunzio si giustificò con la sua grande scaramanzia: doveva
farsi consigliare dagli astri durante la notte, ma non ebbe modo di consultarsi per il cielo nuvoloso.
I rapporti tra i due, come è facile comprendere, non saranno mai idilliaci, e Mussolini cercherà di
tenerlo sotto stretta sorveglianza anche negli ultimi anni di vita al Vittoriale.
L’epopea finì nel Natale del 1920, quando lo Stato italiano fece forza sulla superiorità numerica del
proprio contingente militare e sul maggior sviluppo delle armi belliche per attaccare i legionari. Il 31
dicembre Gabriele D’Annunzio firmò la resa.
La storia della Fiume dannunziana finì ed iniziò a entrare nell’epica. Venne dimenticata per molti
decenni: molti storici la ritenevano un prologo della rivoluzione fascista che sarebbe di lì a pochi anni
avvenuta nel nostro Paese, ma è errato catalogarla in tal modo, dato che, come visto in precedenza,
questa piccola città rappresentò un esperimento sociale in cui far confluire numerose ideologie che
avevano l’unico obiettivo di sovvertire il sistema pre-costituito.
Non hanno vinto, ma i numerosi arditi che seguirono lo scrittore ebbero la sensazione di avere il
mondo in una mano, di poter rappresentare l’Italia nel modo più onorevole possibile, di vivere
un’esperienza unica, in cui il culto della Nazione e la rivendicazione dei propri diritti potevano
convivere.
La lezione attuale è proprio questa: possiamo combattere, protestare, manifestare per avere ciò che
ci spetta anche senza disonorare l’amor patrio che, anzi, deve essere una roccaforte delle nostre
linee. La Nazione è ciò che siamo stati, ciò che siamo e ciò che saremo.
Fiume è l’esempio che bisogna sempre lottare, bisogna stringere i denti e andare sempre contro
quello che riteniamo il più difficile dei nemici. Bisogna disobbedire


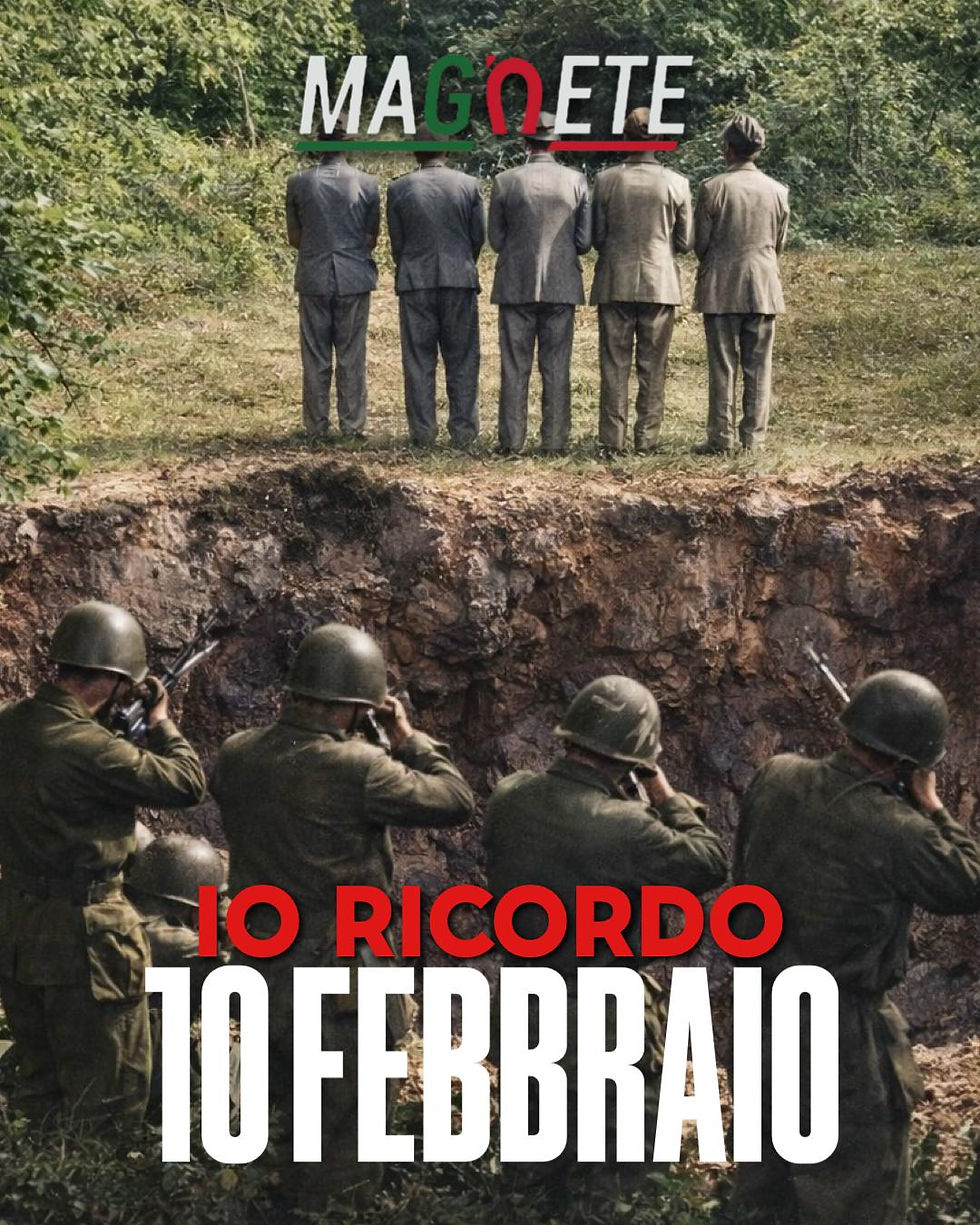

Commenti