Ezra Pound, l’uomo che volle rifare il mondo con le parole
- Redazione

- 1 nov 2025
- Tempo di lettura: 3 min
di Enrico Pellegrini
Non fu soltanto un poeta. Fu un costruttore di mondi, un architetto del linguaggio, un
visionario convinto che la parola potesse rifondare la civiltà. La sua esistenza fu il tentativo, disperato e grandioso, di restituire alla poesia ciò che l’epoca moderna le aveva tolto: il potere di ordinare il caos, di dare forma al destino.
Nel suo volto affilato e inquieto, nella voce febbrile che mescolava latino, cinese, inglese elisabettiano e provenzale, si concentra una certezza che oggi appare quasi mitologica: che la cultura non sia un ornamento, ma una responsabilità.
Pound credeva nella poesia come forma di governo dello spirito. Non dell’arte per l’arte, ma della parola come atto fondativo, come legge morale del mondo.
Ogni poeta, diceva, deve essere accurate, intense and simple. Ma in Pound la semplicità non è mai banalità: è purezza, geometria, rivelazione. Nei suoi versi e nei suoi saggi, nell’ossessiva ricerca della precisione e nella nostalgia per la forma, vive un’idea quasi classica di bellezza: quella che ordina il mondo perché lo comprende.
La sua poesia è architettura morale: la parola come mattone e come misura, come codice e come arma.
Per lui la tradizione non era un museo, ma una miniera viva. Tradusse Cavalcanti e Confucio, Omero e Catullo, non per filologia ma per necessità. Ogni civiltà, pensava, lascia una lingua che può essere rifusa.
Nel suo ideale, il poeta è un fabro, un artigiano del vero. “Make it new” rifallo nuovo, non significa distruggere, ma restaurare ciò che è eterno nell’uomo. La modernità, per Pound, non era rottura ma rinascita.
Il Canto è la sua unità sacra. Nei Cantos, quell’opera immensa e frammentaria, costruita come una cattedrale in rovina, tenta di contenere tutto: storia, economia, arte, mito, amore, usura, fede.
Ogni sezione è una lastra di memoria, un tentativo di dare ordine a un mondo che frana.
La poesia diventa così la cronaca di una civiltà smarrita e la mappa per una nuova.
In Pound il ritmo non è soltanto musicale: è cosmico. La lingua pulsa come un cuore antico.
Ogni sillaba è necessaria, ogni parola è un atto di fedeltà verso l’universo.
Eppure, dentro questa armonia ideale, serpeggia sempre una nota di tormento.
Pound sapeva che ogni costruzione umana porta in sé la propria rovina. Per questo la sua poesia è tanto lucida quanto inquieta: perché sa che la bellezza è fragile, e che la verità, se non diventa carne, non salva nessuno.
Il suo sguardo non conobbe la misura del compromesso.
Credeva nel valore assoluto della cultura, nella necessità di una nuova aristocrazia dello spirito. Nella sua visione, l’uomo moderno era caduto nell’usura del pensiero, nell’economia del nulla. Per lui la poesia doveva essere il contrario del debito: un atto di restituzione alla vita.
In questo c’è qualcosa di profetico e di terribile.
Pound vedeva il mondo come una
struttura spirituale collassata, e voleva rifarla con la parola, come se i versi potessero davvero sostituire le istituzioni, come se l’arte potesse redimere la storia.
Pound credeva, e credeva fino al sacrificio, che la verità fosse una cosa concreta, che la
bellezza potesse reggere un mondo.
In questo, il suo destino non è politico: è teologico.
È il destino di chi ha cercato Dio nell’ordine della parola, e ha finito per smarrirsi nel
disordine degli uomini.
Nel suo silenzio finale, dopo la tempesta, Pound disse soltanto: “Ho perso la fede nella mia capacità di giudicare.”
Era la confessione di un uomo che aveva voluto essere più grande del suo tempo e aveva pagato il prezzo della sua grandezza.
Ma il silenzio non cancella l’opera.
Resta un insegnamento che ci riguarda ancora: la necessità di credere nella parola come atto morale.
Non basta parlare: bisogna dire il vero. Non basta scrivere: bisogna fondare.
Rileggere Pound oggi significa interrogarsi sul senso stesso della cultura.
È ancora possibile pensare la poesia come forma di conoscenza? È ancora possibile credere che la bellezza abbia un potere civile?
Forse no, ma Pound ci costringe a tentare.
Perché in un mondo che ha smesso di pensare, la sua voce resta una ferita aperta, un grido che chiede ordine e luce.
In un’epoca che ha svuotato le parole, la sua ossessione per il significato è un monito.
Ogni poeta moderno gli deve qualcosa: la libertà di rompere le forme, ma anche la
responsabilità di non tradire la lingua.
Dietro ogni verso limpido c’è la sua ombra, la sua lezione: non basta dire, bisogna fare.
Perché la poesia, per Pound, non era un rifugio, ma un dovere.
Ezra Pound muore il 1° novembre 1972, a Venezia.
Muore dove l’acqua riflette le rovine e la gloria del tempo, in una città che gli somiglia: bellissima e imperfetta, luminosa e in declino.
Ma la sua voce resta.
Resta come ammonimento, come promessa, come domanda.
Che cosa resta, dopo Pound, della poesia?
Forse soltanto la fede, quella antica e indomabile convinzione che la parola, se pronunciata con verità, possa ancora cambiare il mondo.



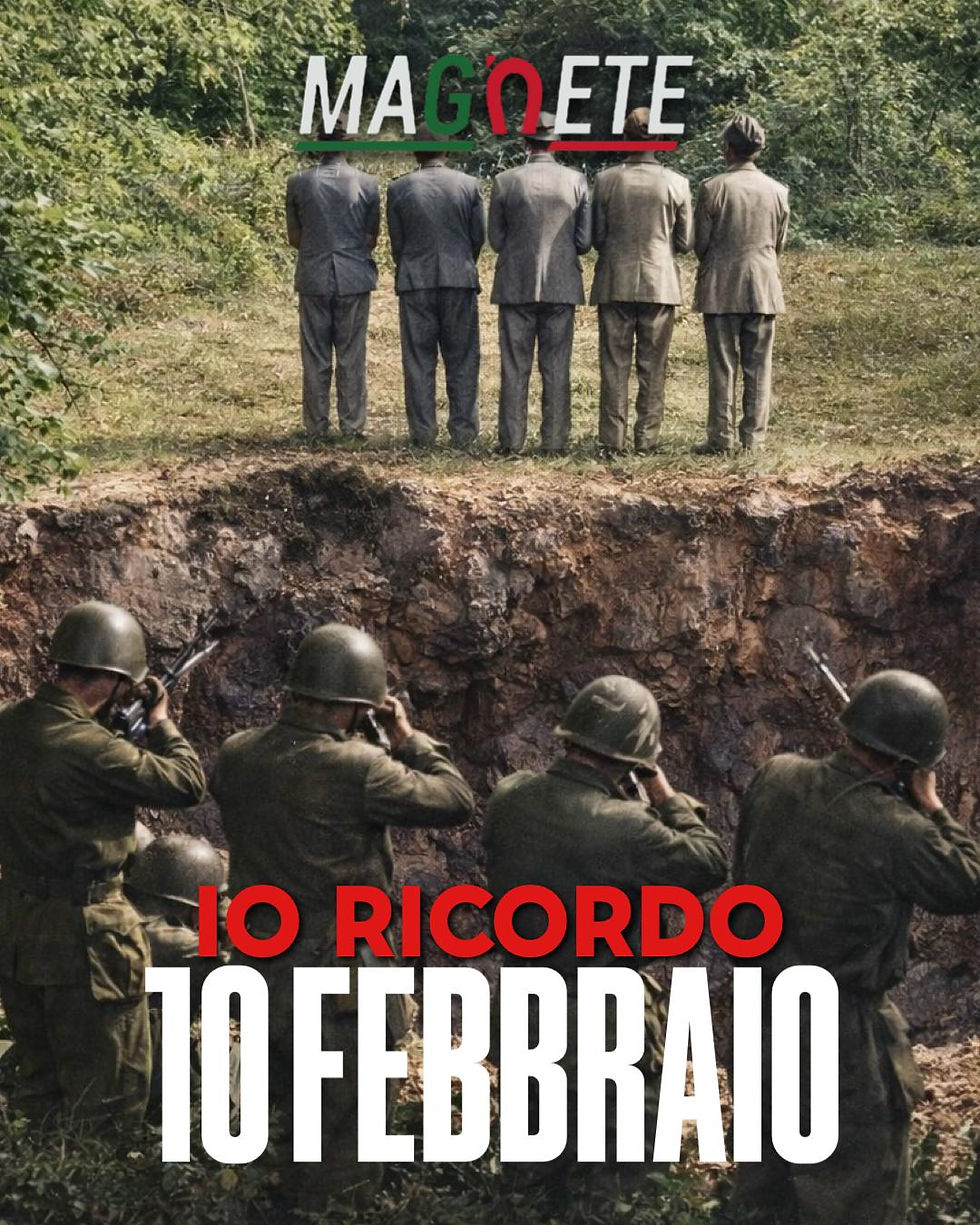

Commenti