Giustizia Giusta
- Redazione

- 6 nov 2025
- Tempo di lettura: 3 min
di Maria Vittoria Giglio
«La riforma che introduce la separazione delle carriere della magistratura è stata
approvata definitivamente dall’aula del Senato. Il disegno di legge costituzionale ha
avuto 112 voti favorevoli, 59 contrari e 9 astensioni.»
Questo il capoverso ripreso da “Il Sole 24 ore” del trenta ottobre duemilaventicinque,
ma in questa storia tanti numeri e passaggi tecnici (o meno) aiuteranno a
comprendere meglio la svolta rappresentata dalla riforma della magistratura.
Partiamo dalla procedura aggravata, nonché “ratio” giustificatrice di interventi mirati alla modifica di disposizioni racchiuse nella Carta, ex art.138, quivi riassunta:
Doppia votazione da parte di entrambe le Camere, per ognuna devono passare tre
mesi.
Per l’approvazione:
Nella prima votazione= maggioranza relativa o semplice (maggioranza dei
presenti)
Nella seconda= maggioranza assoluta (maggioranza dei componenti tutti)
In caso di mancata maggioranza dei due terzi si procede col referendum
confermativo, secondo le modalità dell’art.75.
Sembrava doveroso sottolineare l’esistenza dell’articolo 138, per evitare di incappare
nell’errore, frutto del più becero qualunquismo, concernente l’immutabilità di una delle norme primarie più belle al mondo.
Tuttavia, occorre precisare che vi sono alcune disposizioni contenute nella
Costituzione (i primi dodici articoli, ad esempio), le quali non potranno mai essere
oggetto di rivisitazione; inutile, ma funzionale allo scopo del pezzo è ribadire che la separazione delle carriere non rientra tra le categorie succitate.
Scendendo di titoli, si giunge all’articolo 104, ovvero al cuore pulsante della
macchina riformatrice.
Attualmente il dispositivo sancisce: “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della
Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di
cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli
appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra
professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di
esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono
immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far
parte del Parlamento o di un Consiglio regionale”.
Dal momento che per “separazione” si intende definire dal punto di vista formale, e
quindi sostanziale, la netta divisione tra chi giudica e chi accusa in fase processuale, qualora l’esito della consultazione popolare dovesse essere positivo- come
auspichiamo- al testo verrebbe aggiunto: “La magistratura costituisce un ordine
autonomo e indipendente da ogni altro potere, è composta dai magistrati della
carriera giudicante e della carriera requirente”.
Vieppiù, l’attuale organo governativo della Magistratura, verrebbe sdoppiato:
uno della magistratura giudicante» e l’altro «della magistratura requirente».
Ciò che più preoccupa e maggiormente caratterizza il sistema rosso fuoco è la
radicale trasformazione nella selezione dei membri del CSM.
La novità annovererebbe il sorteggio: I due Consigli non saranno elettivi. Essi
saranno composti per un terzo da membri laici e per due terzi da togati; i primi
saranno estratti a sorte da un elenco di giuristi predisposto dal Parlamento in seduta comune; i secondi saranno sorteggiati tra tutti i magistrati, giudicanti e requirenti, che avranno i requisiti che stabilirà una legge ordinaria successiva. I componenti dei due Csm «durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva».
Altro elemento di preoccupazione per i più, di gioia per il resto sarebbe l'introduzione
dell’Alta corte disciplinare; essa sarà composta da 15 membri:
3 nominati dal Presidente della Repubblica;
3 estratti a sorte da un elenco di giuristi che il Parlamento in seduta comune «compila con elezione»;
6 estratti a sorte tra i magistrati giudicanti con 20 anni di attività e con esperienze in Cassazione;
3 sorteggiati tra i magistrati requirenti con vent’anni di attività e esperienza in
Cassazione.
I togati sono quindi la maggioranza, ma il presidente viene eletto tra i laici. Durano in carica 4 anni, l’incarico non è rinnovabile.
Quattro semplici formule per cercare di rendere migliore e più libera lo snodo
nevralgico di una civiltà giuridica, degna di questo nome.
Perché il mezzo grazie al quale la giustizia si realizza è il diritto e se il diritto è vetusto, o comunque non ideoneo a soddisfare le istanze del tempo corrente è cosa sacra apportare migliorie.
Nel frattempo attendiamo il referendum, secondo le prime indiscrezioni, a marzo dell’anno venturo!



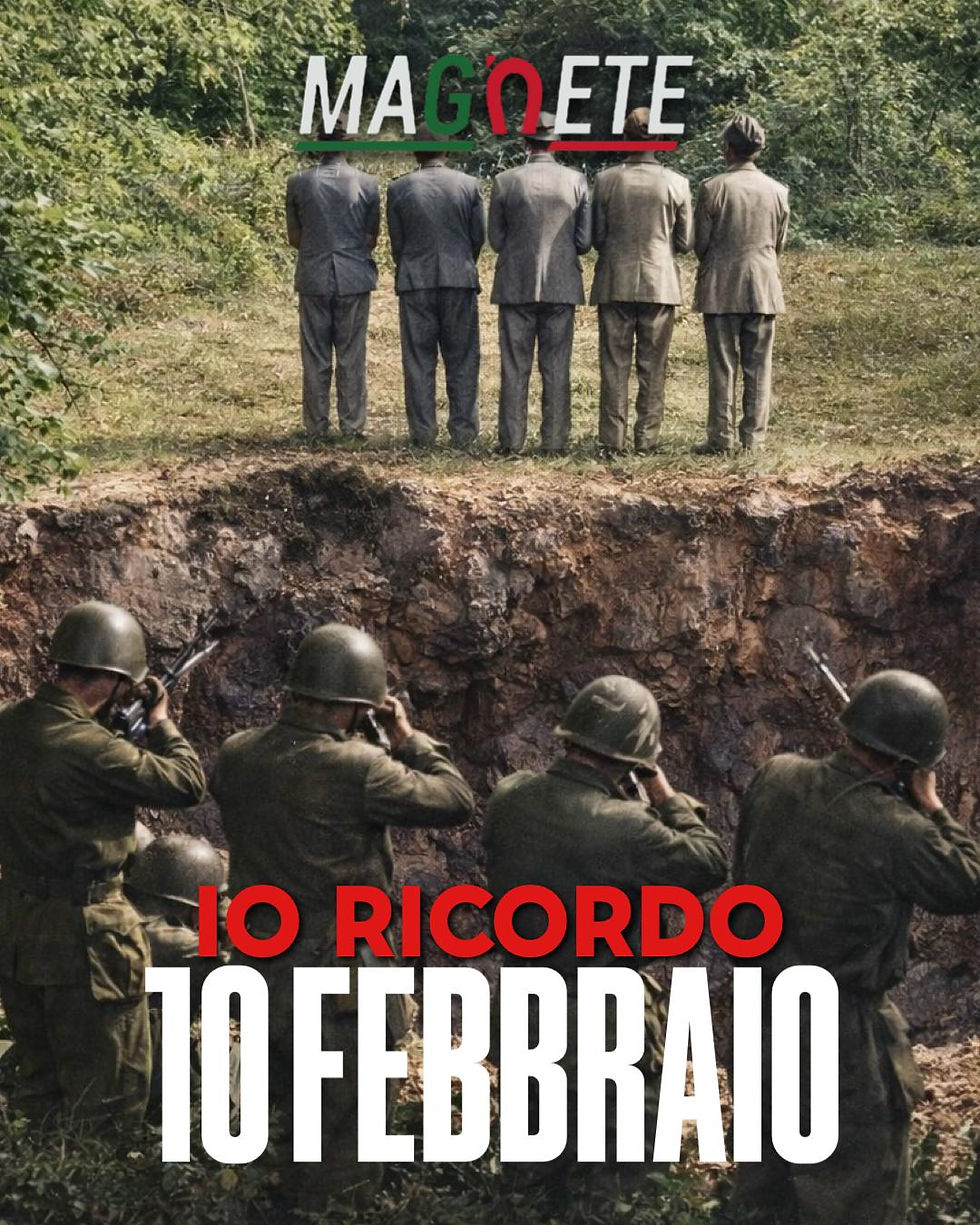

Commenti