Il Tempo del Futurismo
- Redazione

- 23 mar 2025
- Tempo di lettura: 4 min
Di Ilaria Telesca
Un manipolo di eroi, di visionari, di squilibrati.
Chiamateli come volete, ma l’impronta che ha lasciato quella gioventù futurista di certo non ha eguali.
A Roma, in questi mesi, si sta celebrando un movimento difficile da raccontare, impegnativo da comprendere e quasi impossibile da riprodurre.
La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea ospita la mostra intitolata “Il Tempo del Futurismo”: arte vera e propria, a 360 gradi, da quadri a manoscritti, da manifesti a sculture, da installazioni a estratti giornalistici.
L’esposizione celebra l’ottantesimo anniversario dalla scomparsa di Filippo Tommaso Marinetti, fondatore del movimento futurista e perfetto esempio di avanguardismo intellettuale.
In una società che non approfondisce, che si informa con un massimo di 150 caratteri o con video da 60 secondi, non è facile scindere – per poi, immediatamente, ricongiungere – l’avanguardismo della battaglia fisica e quello della guerra interiore, spirituale o mentale che sia.
Il Futurismo celebra la spinta, la rabbia, la forza che (in particolare) gli animi della nostra società, italiana ed europea, dovrebbero nutrire non solo in caso di eventuali campi trincerati ma che, al contrario, dovrebbero possedere prescindendo dalla condizione storico-politica in cui si vive.
Stiamo parlando della confusione della piazza di paese, della forza fisica che permette agli aerei di planare, del desiderio di arrivare nello spazio rimanendo con i piedi ben piantati sulla propria Patria.
Ma anche di quella comparazione tra il dinamismo meccanico equello animale, dell’imprescindibile collegamento tra la natura e la scienza, dell’importanza di fonderle pur mantenendole ben distaccate.
Sono le parole in libertà e le linee di traiettoria di un pugno.
E poi, la forza ascensionale e la velocità del motoscafo. E laguerra, sola igiene del mondo.
Marinetti ci trasmette quella sensazione che involontariamente l’uomo prova prima che si apra il suo paracadute.
Quella linea sottile tra la vita e la morte, quel momento di sintesi tra confusione e consapevolezza.
E ci spinge a cercarla, quella sensazione. Ad averne paura e a bramarla, come eccessivo bisogno di vitalità.
Il Manifesto di Marinetti è un inno alla gioventù, che nulla ha a che fare con la mera età anagrafica, ma che si traduce nel trionfo del futurismo e nella sconfitta del passatismo.
Ora, è bene precisare questo concetto, soprattutto in un contesto in cui spesso si abusa del termine “conservatorismo”. Sia chiaro, non si disprezza così la bontà dell’idea, che guarda a un passato glorioso e cerca in qualche modo di emularlo. Ma come si può pensare di riproporre, decenni o secoli dopo, un trascorso ormai invecchiato? Questa pratica è essa stessa l’antitesi della gioventù, della nuova generazione, del così blaterato futuro.
E no, non sarà mai questa una sponda al progressismo, concetto malato del tempo e dello spazio, che contamina la realtà e la rende succube di uno sviluppo effimero e materiale, che stermina il contemporaneo senza costruire alcun degno avvenire.
Il Futurismo è quella famosa terza via; è l’essenza che non accetta passività - che sia quest’ultima sinonimo di devozione al passato o di urgente bisogno di novità.
È un re-inventarsi, prendere ciò che “è stato”, adattarlo all’attuale spazio-tempo senza in alcun modo denaturarlo, per fare in modo che lo stesso processo possa avvenire per la successiva costruzione del “sarà”.
Marinetti ci aiuta a disprezzarla, quella passività, tipica di una società borghese, stanca e annoiata dalla sua lentezza.
Ci propone invece una vita dinamica, feroce e audace, conseguente alla ripudiata inerzia.
Il movimento diventa antidoto contro l’omologazione, contro l’appiattimento del pensiero e la pigrizia del corpo.
L’idea futurista di tecnologia, di scienza applicata alla realtà, è quanto di più attuale possa esistere.
Marinetti ci racconta, con le parole e con l’ingegno, un’Intelligenza Artificiale degli inizi del ‘900, una rivoluzione mentale nel secolo delle rivoluzioni belliche.
Ognuno di noi ha una propensione particolare. Il Novecento è stato il secolo delle rivoluzioni perché la violenza, necessaria a smuovere gli animi, ha svolto il ruolo di protagonista.
Non si tratta di picchiatori, partigiani o squadristi, ma il concetto di violenza si tramuta nei due sentimenti più potenti che l’uomo possa provare: l’odio e l’amore.
L’amore è l’idea, nonché il desiderio di concretizzare il pensiero in favore di una comunità e di una Patria; l’odio è l’incapacità ditrasmetterla e di realizzare quel sogno, vuoi per impossibilità o per inesperienza.
E questi due sentimenti, vivi nell’uomo del secolo scorso, hanno portato a un dinamismo violento, nel senso più puro del termine, così forte da non poter più essere oppresso. Da qui le rivoluzioni, fisiche con le guerre e intellettive con quei movimenti filosofici che questa necessità di esplosione l’avevano compresa e avevano cercato di spiegarla.
Non bisogna allontanare a priori il concetto di violenza, inteso come forza che infiamma gli animi; la rabbia è indispensabile soprattutto per la gioventù. Bisogna però capire come utilizzarla.
Agli inizi del Novecento, Marinetti esaltava la scienza e invitava a bruciare musei e biblioteche. Perché era necessario! Perché quei luoghi di sola cultura e solo studio del passato addormentavano l’animo umano e affievolivano l’ira. Proprio quei luoghi da lui disprezzati ma essenziali per far rivivere le sue idee, oggi ospitano la sua arte.
Sarà estremamente contento, F.T.M., quando ad esaltare il Futurismo ci penserà l’IA, se e solo se saremmo stati in grado di comprenderne le potenzialità senza farci sterminare.
Dopo ottant’anni il nostro compito è quello di raccogliere i frutti del Movimento rivoluzionario di Marinetti, re-inventandoci proprio come lui, senza lasciare che una banale innovazione tecnologica prenda il sopravvento, ma assorbendo il passato, i suoi valori e i suoi insegnamenti, dominando il presente e cavalcando il futuro.
Dobbiamo surfare tra onde di oceani diversi, farci spazio tra una cultura millenaria e l’imprevedibilità di quello che tocca a noi costruire, approfittare dei valori tradizionali che ci mantengono ancorati alla Patria e ambire a portare quei valori fino allo spazio.
E allora scagliamo la nostra sfida alle stelle, partendo dai nostri piccoli borghi che spesso sembra non abbiano niente di futuristico.
Diamo velocità a quel mito effimero della “vita lenta”, che caratterizza superficialmente i nostri luoghi ma che non è in grado di valorizzarne le peculiarità. Diamo forma alla bellezza che solo nella lotta può realizzarsi. Cantiamo le folle, la comunità, il nostro vicino di casa. Inneggiamo al pericolo, all’incerto, alla cultura che spazia tra animo e scienza.
Diamo un senso alla politica, riconsegniamole potenza e vivacità.
Diamo priorità alla dinamicità della gioventù, riscoprendoci figli di un’idea geniale.
Lunga vita ai Futuristi, amanti dei valori autentici ma con lo sguardo rivolto all’avvenire!


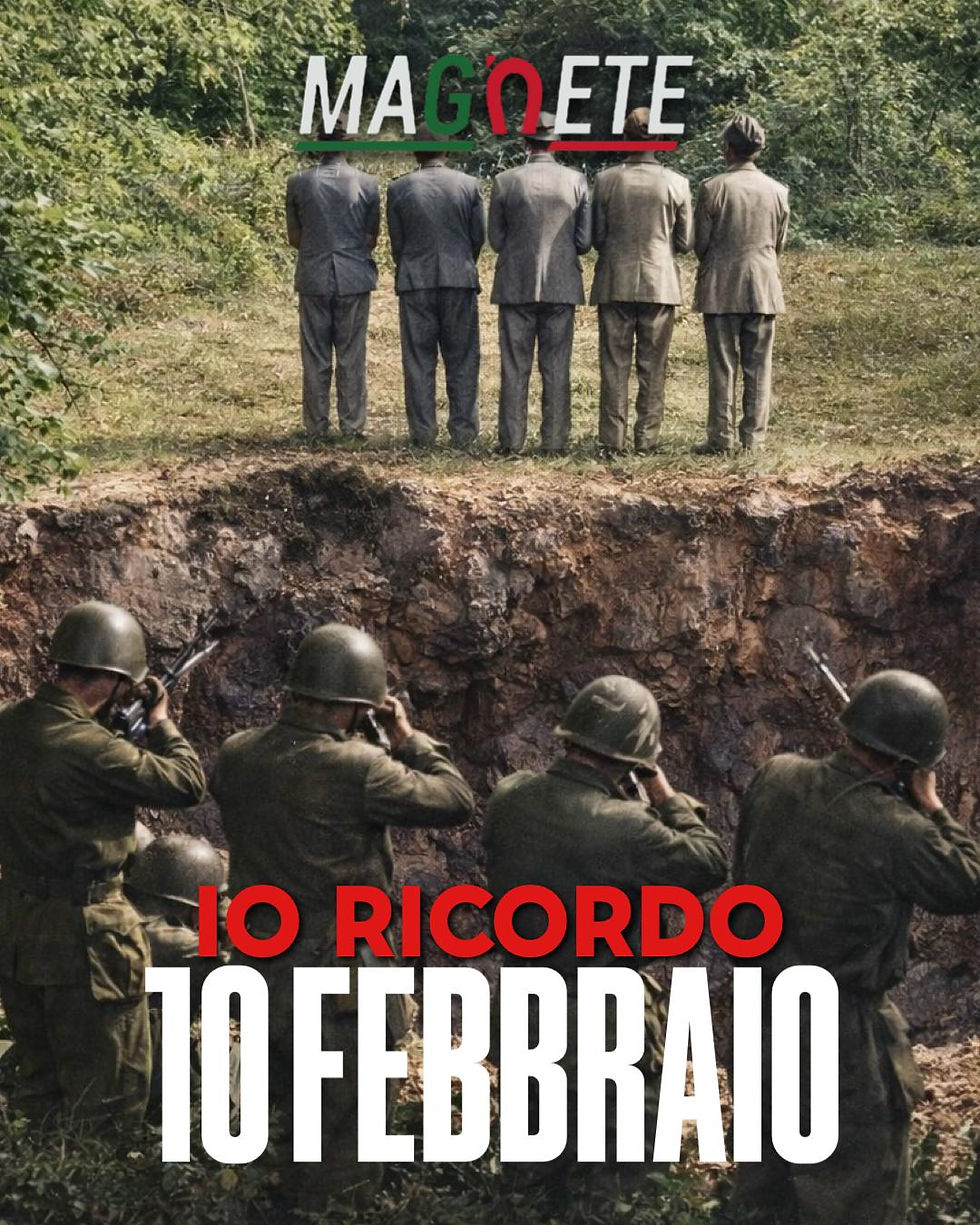

Commenti