Salviamo il calcio di provincia
- Redazione

- 19 nov 2025
- Tempo di lettura: 4 min
di Pasqualino Santoro
Il calcio di provincia è morto.
O meglio, sta morendo lentamente, soffocato da una malattia che si chiama denaro.
Non parliamo di Serie A, di sceicchi arabi o di fondi americani che comprano sogni a suon di miliardi, ma parliamo di Promozione, di Prima e Seconda categoria, parliamo di campi in terra battuta, di spogliatoi che puzzano di umido, di presidenti che mettono mano al portafoglio per pagare il pullman e la cena post-partita. Parliamo di paesi dove la squadra era l’anima del luogo e ora è solo un bancomat ambulante: prendete un qualsiasi paesino di tremila anime, uno di quelli con la piazza, la chiesa e il bar dove bere una birra post-partita.
Dieci anni fa, la squadra locale era composta da ragazzi del posto: il figlio del meccanico in porta, il nipote del farmacista in difesa, il barista che correva come un matto a centrocampo, il ragazzo disoccupato che nonostante tutto lotta per il paese.
La domenica, il paese si svuotava e si andava tutti allo stadio, con la sciarpa cucita dalla nonna e la bottiglia di vino nascosta nello zaino. Si vinceva o si perdeva, ma si era insieme, si cantava e ci si divertiva, perché in quel campo con l’emblema identitario c’erano gli amici e conoscenti di chi urlava dagli spalti.
Quella era l’identità. Quella era l’appartenenza.
E poi c’erano i tifosi, quelli veri. Che partivano in pullman alle sei del mattino per una trasferta a quaranta chilometri, con la puzza di fumogeni che impregnava i sedili e il sudore che colava sotto le maglie. Che pagavano il biglietto d’ingresso, il panino unto al bar dello stadio, la benzina per il ritorno.
Spesso ci rimettevano di tasca propria: 20 euro, 30, a volte 50. Non per vedere fenomeni calcistici, ma per urlare il nome del terzino del paese, per difendere i colori di casa in un campo ostile. Tornavano a notte fonda, con la voce rauca e il portafoglio più leggero, ma con il cuore pieno. Perché quella era passione, quella era fedeltà.
Oggi?
Il figlio del meccanico gioca a trenta chilometri di distanza, in una squadra che gli dà 400 euro al mese. Il nipote del farmacista è passato al club rivale perché gli hanno promesso il rimborso benzina e un bono per le scarpe. Il barista? Ha smesso. “Non mi diverto più”, dice, e ha ragione.
E i tifosi? Sempre meno. Perché andare in trasferta a vedere undici sconosciuti che cambiano maglia ogni anno non ha senso. Perché spendere soldi per una squadra che non rappresenta più nessuno.
Il denaro è entrato anche qui, nelle categorie dilettantistiche, come un virus. Non parlo di stipendi da capogiro, ma di quelle piccole cifre che bastano a far girare la testa. 200 euro al mese, 300, a volte 500. Per un ragazzo di vent’anni che lavora in fabbrica o fa il muratore, sono soldi veri. Sono la differenza tra una birra al bar e una vacanza a Riccione, sono la differenza tra restare e andarsene.
E così i paesi si svuotano, le squadre di provincia diventano contenitori vuoti, riempiti da mercenari che arrivano da fuori, giocano una stagione e se ne vanno, e lo stesso vale per i ragazzi del post, che preferiscono il denaro all’identità, al valore della maglia. Non conoscono la storia del club, non sanno chi fosse il presidente degli anni ’80 che ha costruito gli spogliatoi con le sue mani, non gli interessa il derby con il paese accanto che dura da tre generazioni.
Giocano, incassano, spariscono.
Il risultato? Squadre senza anima, e identità di paese che muoiono, andando a creare anche una lamentela generale, che porta a chiedere perché non c’è la squadra del paese? Tifosi che non vanno più allo stadio perché non riconoscono nessuno in campo, né in panchina né in curva. Presidenti che si indebitano per tenere il passo con i club più ricchi, che a loro volta si indebitano per tenere il passo con altri ancora.
Una spirale perversa che porta al fallimento, alla fusione, alla sparizione.
Eppure, il calcio di provincia potrebbe essere salvato. Non con più soldi, ma con meno, con regole ferree: divieto di rimborsi oltre una certa cifra, obbligo di tesserare un numero minimo di giocatori del posto, incentivi fiscali per i club che investono nei settori giovanili locali, lotta ai contributi dati a “nero” e soprattutto lotta a quelle dirigenze corrotte che sfruttano il calcio per lavare denaro sporco. Con una cultura che premi l’appartenenza, non il portafoglio.
È proprio questo il fattore più importante, la cultura dell’appartenenza e l’appello che si vuole fare è di lasciar perdere promesse irrealistiche e riscoprire la bellezza di lottare per la propria maglia, per il proprio paese, per quel vecchio allenatore che ha visto crescere ragazzi che oggi si vendono al denaro. Che riconosca il valore di chi, ogni domenica, si alza all’alba, accende il fumogeno e parte, anche se ci rimette.
Perché il calcio non è solo un gioco. È memoria. È identità. È il modo in cui un paese si racconta. E se perdiamo questo, perdiamo tutto.
Salviamo il calcio di provincia. Prima che sia troppo tardi.



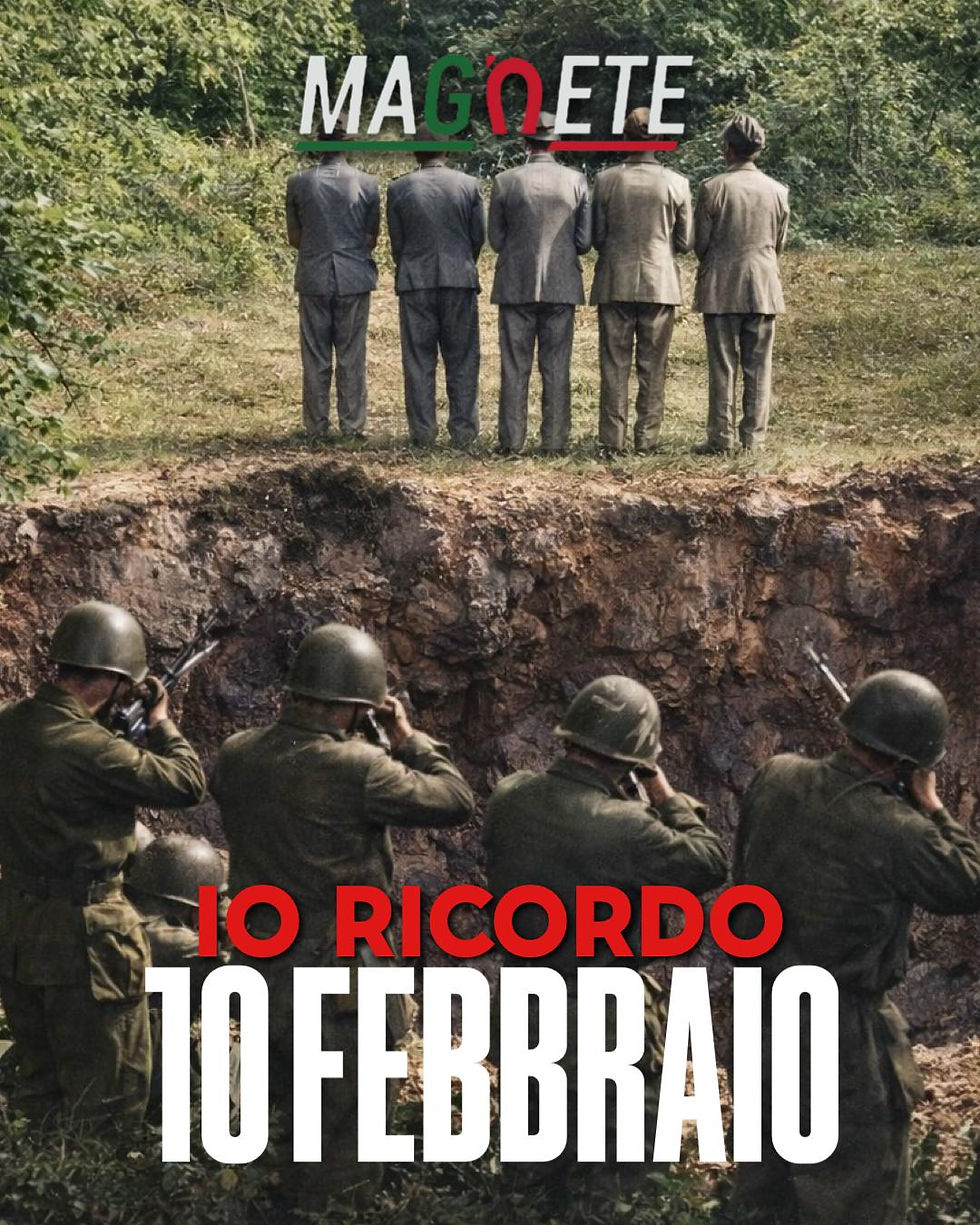

Commenti