Uccidere il Padre
- Redazione

- 10 apr 2025
- Tempo di lettura: 8 min
Di Alessio Moroni
Il Sessantotto è universalmente ricordato come l’anno della contestazione studentesca di sinistra. Quasi sempre, infatti, studenti e ragazzi di destra vengono esclusi da questo racconto, poiché l’accostamento “destra–’68” sembra a molti «antistorico e impraticabile». Eppure, anche nella destra giovanile italiana del 1968 si accesero fermenti di ribellione generazionale. I giovani missini vissero quell’anno con passione, tra aspirazioni di cambiamento radicale e fedeltà a un partito invece orientato all’ordine. Ne scaturirono mobilitazioni studentesche parallele a quelle della sinistra, ma anche forti contrapposizioni interne al MSI.
In quel periodo anche molti giovani di destra avvertivano gli stessi disagi e slanci dei coetanei di sinistra. Il movimento di contestazione fu innanzitutto generazionale: un’intera generazione di studenti si ribellò contro l’autorità costituita, l’università antiquata e la società dei padri
In questo clima, alcuni ragazzi della Giovane Italia e del Fronte Universitario d’Azione Nazionale (FUAN) – rispettivamente l’organizzazione giovanile missina e il movimento degli studenti universitari di destra – iniziarono a partecipare attivamente alle proteste anti-sistema. Episodi come la battaglia di Valle Giulia(1º marzo 1968) videro fianco a fianco, seppur occasionalmente, studenti di opposte ideologie uniti contro il comune bersaglio dell’autorità costituita (in quel caso, la polizia). Come ricordò un dirigente missino dell’epoca, a Valle Giulia emerse «un’intera generazione che si ribella contro il sistema» e venne distrutta in pochi giorni la vecchia mentalità passiva.
Sull’onda delle occupazioni studentesche, in varie università italiane i militanti del FUAN parteciparono alle assemblee e manifestarono – pur con parole d’ordine diverse – per chiedere riforme nell’istruzione e contestare il sistema. Per esempio, a Roma nacque il gruppo Primula Goliardica e circolò un “Manifesto degli studenti europei” di destra, tentativi di inserirsi nel movimento studentesco con proprie proposte. Questa frangia di destra contestataria venne bollata dalla sinistra come “nazi-maoista” per la curiosa combinazione di slogan antiborghesi e richiami nazionalisti. In sostanza, una parte della gioventù neofascista provò a confluire nella grande ondata del Sessantotto, sposandone in parte i temi (antiamericanismo, critica al capitalismo, lotta al “sistema borghese”) ma declinandoli in chiave nazional-rivoluzionaria.
Nel 1967-68 con l’esplodere della contestazione generale, la base giovanile missina iniziò a dividersi: alcuni restarono sulle posizioni tradizionali, altri invece desideravano partecipare al vento di cambiamento. Nasceva così una destra giovanile “di lotta”, per nulla disposta a restare ai margini mentre i coetanei di sinistra guidavano la protesta nazionale.
Mentre nelle università i giovani missini vivevano la stagione della rivolta, la linea ufficiale del MSI rimaneva diffidente e moderata. Il partito, guidato in quegli anni da Arturo Michelini, perseguiva la “normalizzazione” post-fascista: Michelini era fautore del superamento del fascismo in favore di posizioni conservatrici e ben inserite nel sistema parlamentare. In sostanza, la dirigenza missina puntava ad accreditarsi come destra d’ordine, anticomunista e rispettosa delle istituzioni. Di fronte alle occupazioni studentesche e ai moti del ’68, la reazione ufficiale del MSI fu ostile: i leader anziani vedevano nella contestazione un pericoloso sovvertimento di piazza istigato dalla sinistra extraparlamentare. La consegna per i militanti era quindi di non mescolarsi con i ribelli “rossi” e difendere semmai l’ordine costituito.
Questa posizione pruente generò immediatamente attriti con le organizzazioni giovanili del partito. Già nei primi mesi del ’68, molti giovani missini mal sopportavano l’atteggiamento attendista dei “padri”. Nelle sezioni giovanili e nelle federazioni universitarie ferveva il dibattito: partecipare o no alle assemblee del movimento studentesco? Alcuni leader giovanili di spicco – ad esempio Adriano Romualdi, figlio d’arte e intellettuale di destra – criticarono apertamente l’immobilismo del MSI. Romualdi accusò la destra ufficiale di aver praticato un «perbenismo imbecille», lasciando che la sinistra monopolizzasse la bandiera della rivolta contro l’ordine borghese. Nel 1970 egli scrisse con amarezza che, mentre i giovani chiedevano parole d’ordine nuove, «dall’altra parte – quella della destra – non c’era più nulla […]. In un’epoca di crescente eccitazione dei giovani, essa diceva loro “statevi buoni”». Questo distacco dalla realtà giovanile portò molti ragazzi di destra a guardare altrove: se il MSI li invitava alla calma, essi sentivano invece il richiamo della piazza e dell’azione diretta, esattamente come i loro avversari rossi.
Nei primi mesi del 1968 la tensione interna salì. Da un lato la segreteria missina inviava richiami all’ordine ai giovani militanti perché abbandonassero le assemblee unitarie di facoltà. Dall’altro, una parte del FUAN – capeggiata a Roma da studenti come Gianni Accame, Luciano Laffranco e altri – continuava a dialogare col movimento studentesco, rivendicando per la destra un ruolo attivo nella contestazione. Questa fronda giovanile percepiva che le rivolte avevano radici in problemi reali (l’università di massa, la disoccupazione intellettuale, la crisi dei valori tradizionali) e che la destra doveva dare risposte, non solo bastonate. Persino un filosofo tradizionalista come Julius Evola riconobbe che la contestazione aveva un’anima non esclusivamente marxista: nel febbraio 1968 pubblicò L’arco e la clava, saggiando l’idea di una “gioventù anarchica di destra” in rivolta contro il conformismo borghese. Il terreno per una conflittualità generazionale all’interno del MSI era pronto: da una parte i dirigenti storici, custodi dell’ordine e timorosi di derive estremiste; dall’altra molti giovani militanti, affascinati dall’onda rivoluzionaria e intenzionati a “fare come i compagni” – ma a modo loro.
La frattura latente esplose drammaticamente il 16 marzo 1968all’Università La Sapienza di Roma. In quella data era in corso un’importante assemblea nazionale del Movimento Studentesco di sinistra, con delegati arrivati da tutta Italia, ospitata nell’aula magna della Facoltà di Lettere. Nonostante i divieti impartiti dal MSI, alcuni giovani missini “eretici” erano presenti tra il pubblico, decisi a portare la voce di una destra rivoluzionaria. La dirigenza del partito decise però di agire per mettere fine a quella che definiva la “deriva rossa” nelle università. All’alba del 16 marzo, il MSI organizzò una contro-mobilitazione: centinaia di militanti di destra – in gran parte non studenti, reclutati nelle sezioni – furono radunati con l’obiettivo di sgomberare l’ateneo occupato. Verso mezzogiorno, un corteo di circa 300 attivisti missini fece irruzione alla Città Universitaria . In testa c’erano due noti esponenti della “vecchia guardia”: Giorgio Almirante(futuro segretario del MSI) e l’onorevole Sandro/Giulio Caradonna, leader romano dal pugno di ferro.
I testimoni ricordano la scena impressionante: i missini avanzarono con tricolori tramutati in manganelli (le bandiere erano arrotolate attorno ai bastoni) intonando slogan come “Boia chi molla” e inneggiando alla RSI. Raggiunta la Facoltà di Lettere, assaltarono l’assemblea a colpi di bastone, scatenando il panico tra gli studenti. Sulle scale di Lettere infuriò la rissa: ne seguì uno scontro corpo a corpo fra i “mazzieri” neofascisti e gli studenti di sinistra asserragliati dentro l’aula. Dopo alcuni minuti di violenza, i giovani di sinistra riuscirono a respingere gli aggressori, che indietreggiarono e ripiegarono nel vicino edificio di Giurisprudenza. Caradonna e Almirante vennero avvistati sulla scalinata di Legge, mentre incitavano i loro a tenere la posizione.
Solo all’arrivo massiccio della polizia l’assalto ebbe fine: gli squadristi missini furono bloccati all’interno della facoltà di Giurisprudenza e identificati dalle forze dell’ordine. In totale si contarono oltre 150 fermati, provenienti da varie parti d’Italia (nessuno risultò essere studente dell’ateneo). L’operazione si concluse con 52 arresti e 172 denunce tra le file missine, oltre a numerosi feriti da ambo le parti. Questi fatti, definiti dalla stampa come “spedizione punitiva di destra alla Sapienza”, ebbero un’enorme risonanza. A livello immediato, l’irruzione riuscì nel suo intento tattico: l’assemblea nazionale studentesca fu dispersa e l’ordine accademico momentaneamente ripristinato.
Ma sul piano politico e morale provocò una frattura insanabile tra la generazione dei padri e quella dei figli missini. Quel 16 marzo, in apparenza, vide tutta la destra – giovani e anziani – unita in un’azione reazionaria contro i contestatori; in realtà segnò il culminare di uno scontro interno senza precedenti. Molti ragazzi di destra rimasero scioccati e indignati nel vedere i propri al fianco della polizia e intenti a picchiare altri giovani . La delusione fu cocente: i “padri” si rivelavano, agli occhi dei figli, come estremi difensori di quel sistema borghese che anche i giovani missini avrebbero voluto combattere, rivendicando il diritto alla rivolta generazionale al pari dei coetanei di sinistra Lo scontro della Sapienza divenne subito un episodio simbolico. Da un lato, confermò agli osservatori esterni l’immagine del MSI come partito legato alla violenza squadrista e nemico del movimento studentesco. Dall’altro, spaccò definitivamente il mondo giovanile. In pratica, dopo il 16 marzo 1968 nulla fu più come prima nella destra italiana: la convivenza tra l’ala movimentista e la linea moderata era divenuta impossibile.
Nel periodo successivo al marzo 1968, la destra giovanile “ribelle” prese strade sempre più autonome dal MSI. Molti militanti del FUAN abbandonarono la “casa madre” missina, accusata di conservatorismo traditore, e si avvicinarono a gruppi extraparlamentari di destra radicale. Già nei mesi immediatamente seguenti, a Roma Stefano Delle Chiaie – carismatico attivista espulso dal MSI – raccolse diversi studenti delusi nelle file della sua Avanguardia Nazionale, organizzazione neofascista più incline allo scontro di piazza. Allo stesso tempo, altri giovani cercarono di portare avanti l’embrione di discorso rosso-neroemerso nel ’68: nacquero piccole formazioni originali, come Lotta di Popolo (fondata a Roma nel 1969), che provò a coniugare riferimenti ideologici della destra con elementi della cultura di sinistra. Lotta di Popolo, ad esempio, mescolava nei suoi volantini citazioni di Nietzsche e Céline con quelle di Malcolm X e Mao Zedong. Tali esperimenti ebbero vita breve e seguito limitato, ma rappresentarono un segnale di come il sommovimento ideologico provocato dal ’68 avesse toccato anche l’estrema destra, spingendola a rinnovarsi in forme inedite.
Il MSI, dal canto suo, dovette correre ai ripari per ricompattare il fronte giovanile. Dopo la morte di Michelini (1969) e la nuova segreteria di Giorgio Almirante, il partito cercò di recuperare i “figli perduti”. Nel 1971 le due principali organizzazioni giovanili rimaste – il Raggruppamento Giovanile Studenti e Lavoratori (erede della vecchia Giovane Italia) e il FUAN – vennero fuse per dar vita al nuovo Fronte della Gioventù (FdG), con l’intento di creare una struttura unitaria e più vicina alle istanze militanti. Alcuni leader giovanili turbolenti rientrarono nell’alveo missino, altri ne rimasero fuori scegliendo la lotta extraparlamentare.
Gli anni ’70 si aprirono così con una destra giovanile profondamente cambiata dall’esperienza del ’68: più radicale nei contenuti (si pensi alla crescente retorica antisistema e antiborghese che portò frange neofasciste a teorizzare l’“attacco frontale allo Stato”), e al tempo stesso più consapevole di sé come forza generazionale autonoma.Sul piano simbolico, la “notte dei bastoni” del marzo 1968 lasciò cicatrici indelebili. Da allora in poi, la gioventù missina (e post-missina) conserverà una certa diffidenza verso i compromessi istituzionali, rivendicando orgogliosamente il proprio spirito di lotta. Non a caso, il 1968 è ricordato da molti come l’atto di nascita di una “destra di popolo”, contrapposta alla destra d’ordine tradizionale. Nel bene e nel male, l’onda lunga di quella stagione agitata contribuì a rinnovare l’ideologia della destra italiana: dalle macerie del conformismo patriottardo attaccato da Romualdi, emersero nuove sintesi, nuovi miti giovanili e un’attitudine movimentista che in futuro sarà parte integrante della destra (basti pensare alle mobilitazioni del Fronte della Gioventù negli anni ’70 e al ruolo di quei giovani negli eventi successivi, come i moti di Reggio del 1970.
Rileggere quel periodo con occhi obiettivi significa riconoscere ai giovani di destra del Sessantotto il loro posto nella Storia. Non erano semplici comparse reazionarie, ma protagonisti di un dramma generazionale: da un lato idealisti desiderosi di cambiare il mondo, dall’altro custodi di una tradizione che temeva di sfuggirgli di mano. Il loro percorso, fatto di lotte, errori e passioni, ha lasciato un’eredità complessa. Oggi, nella comunità militante che anima un partito come Fratelli d’Italia, resta viva la memoria di quei giovani coraggiosi e delle loro battaglie – memoria che serve da monito e da ispirazione per affrontare le sfide del presente con la stessa fiamma ideale.


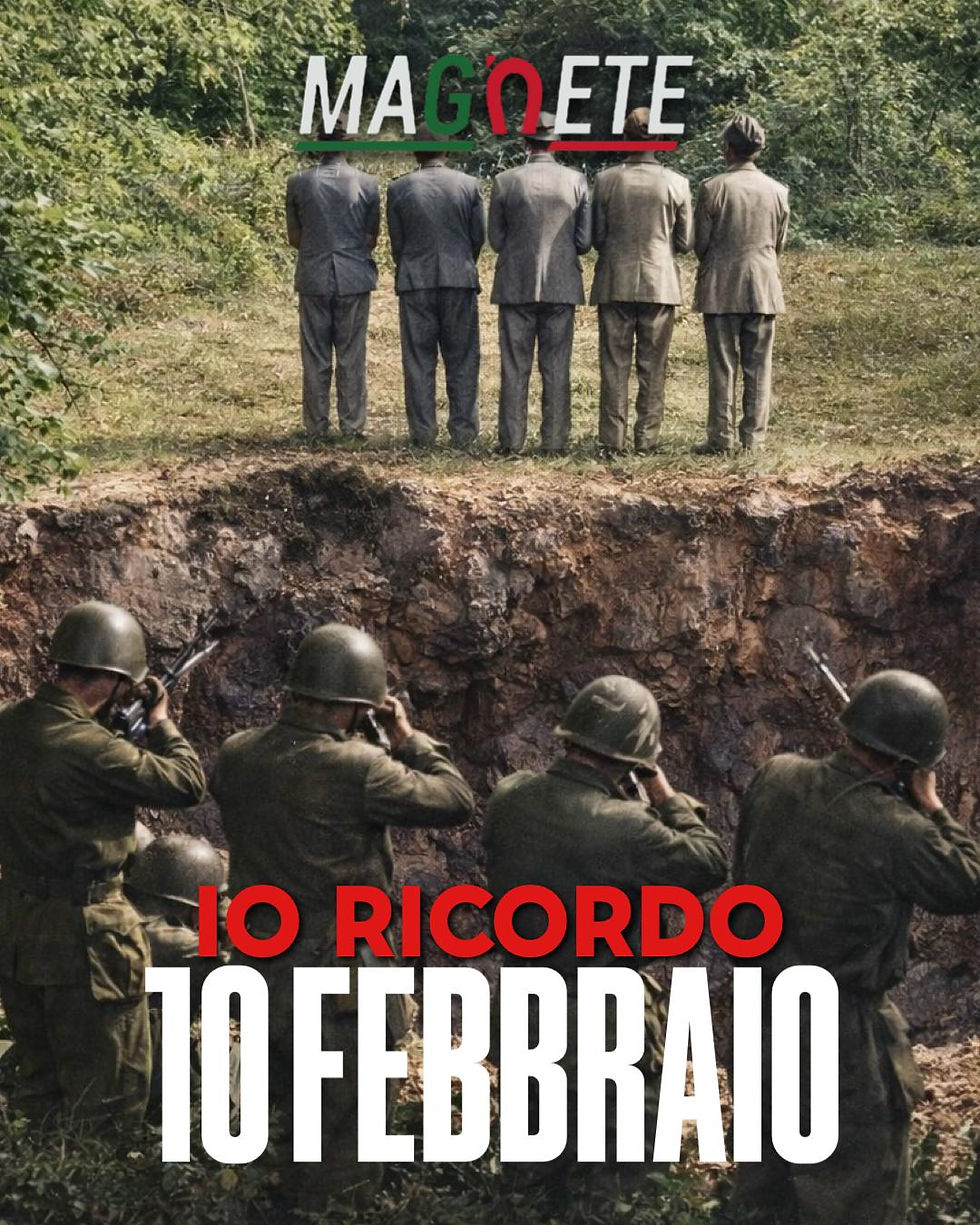

Commenti